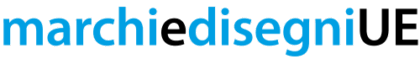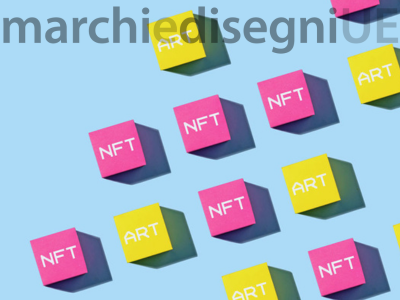Il caso Nike v. StockX fornisce aggiornamenti
Qualche anno fa, agli albori della rivoluzione digitale 4.0, le prime pagine di tutti i giornali erano dedicate al tema dei non-fungible tokens (NFT). Si tratta di un codice unico (e, per tale ragione, infungibile), che garantisce l’identità ed originalità di qualsiasi prodotto, fisico o digitale, ad esso associato. Tramite gli NFT, dunque, si dispone di una nuova modalità di certificazione digitale unica, registrata in una blockchain, da utilizzare per ottenere l’attestazione della titolarità di un bene. Agli NFT è possibile attribuire la caratteristica di aver introdotto la “scarsità” nel mondo digitale, tenendo in considerazione che, come per ogni altro file digitale, essi possono essere facilmente duplicati, ma, in ogni caso, il codice univoco contenuto, validato da ogni nodo della blockchain, garantisce che, anche tra una molteplicità di copie, sia possibile individuare e distinguere l’unico l’originale.
Nel 2022, il caso emblematico del complesso rapporto fra NFT e diritti di proprietà industriale, in particolare diritti di marchio, è stato rappresentato dalla contesa tra Hermès International e l’artista Mason Rotschild, conclusasi, nel primo grado di giudizio, l’anno successivo con la sentenza emessa da una Corte distrettuale newyorkese: secondo la stessa, la commercializzazione di NFT relativi a una collezione di Birkin (denominate, per le proprie caratteristiche, “MetaBirkin”) avrebbe costituito violazione e diluizione dei diritti di marchio della maison francese e l’attività dell’artista non sarebbe stata compresa nell’applicazione del Primo Emendamento dedicato all’espressione artistica. Tuttavia, l’artista ha presentato appello e la vicenda pare ancora lontana dalla propria conclusione definitiva.
Un’altra disputa aperta nel 2022, sempre relativa a NFT e marchi, ha ottenuto un nuovo impulso nei giorni scorsi. Si tratta del caso indicizzato come Nike, Inc. v. Stock LLC, proposto nel febbraio 2022 dinanzi ad una Corte federale dello Stato di New York. Tramite tale azione legale, la multinazionale statunitense fondata in Oregon negli anni ’60 e leader mondiale dell’abbigliamento e degli accessori sportivi ha convenuto la società a cui si riferisce l’omonima piattaforma online di vendita e rivendita di abbigliamento e calzature, considerando le medesime basi giuridiche indicate nel paragrafo precedente. StockX aveva, infatti, lanciato un servizio di autenticazione e tracciamento dei prodotti acquistati sulla piattaforma che, secondo la prospettiva di Nike, avrebbe condotto i consumatori a ritenere che il sistema, quando riferito ai prodotti a marchio Nike, fosse stato autorizzato dalla multinazionale stessa. La convenuta, tuttavia, aveva replicato alle allegazioni di violazione di marchio, diluizione e concorrenza sleale segnalando che il consumatore sarebbe stato reso edotto immediatamente del fatto che i prodotti acquistati, autenticati dal sistema di StockX, sarebbero stati allocati in un caveau digitale. Tramite tale sistema, sarebbe stato possibile, per i consumatori, sia riscattare il prodotto fisico collegato a ciascuno degli NFT, sia trasferire gli stessi tramite blockchain.
In replica a tali difese, Nike aveva aggiunto ulteriori istanze alle proprie memorie, con l’intento di ampliare l’ambito dell’azione: secondo l’attrice, infatti, gli elementi forniti rendevano necessario, altresì, l’accertamento dei comportamenti di contraffazione e pubblicità ingannevole. A tali argomenti, StockX aveva replicato evidenziando che il comportamento di Nike costituisse esso stesso un tentativo di violazione della libera concorrenza, al fine di sferrare un attacco, nemmeno troppo velato, al settore delle rivendite.
Nel marzo 2025, il giudice competente per la causa ha affermato che la decisione della vicenda, con riferimento ai temi di violazione di marchio e pubblicità ingannevole, spetterà ad una giuria. Al contempo, è stata emessa una decisione all’esito di un procedimento sommario per contraffazione: StockX è stata, infatti, ritenuta responsabile di aver venduto circa una trentina di scarpe identificate con i marchi di titolarità di Nike, ma mancanti del requisito di originalità. Tuttavia, tale suddivisione non pare aver soddisfatto l’attrice, che, con una nuova mozione datata luglio 2025, ha proposto di suddividere ulteriormente le allegazioni al fine di separare i temi di pubblicità ingannevole e contraffazione, che saranno posti all’attenzione della giuria, dai temi di violazione e diluizione di marchio, i quali dovrebbero, invece, essere oggetto di una nuova decisione resa unicamente dalla Corte.
La disputa pone in luce una varietà di dinamiche, sia dal punto di vista del tema affrontato sia con riferimento alla necessità di considerare con la dovuta attenzione la strategia di enforcement dei propri diritti. Nei giorni scorsi, infatti, anche un ulteriore caso collegato agli NFT ha attirato l’attenzione di esperti e curiosi. Si tratta dell’azione per violazione di marchio proposta dalla società Yuga Labs Inc. nei confronti dell’artista Ryder Ripps e dello sviluppatore Jeremy Cahen. La Corte d’appello statunitense competente, infatti, ha emesso una decisione in contrasto con quanto precedentemente affermato dalla Corte di merito, sostenendo che quest’ultima avesse impropriamente reso la propria sentenza senza coinvolgere una giuria. L’azione legale, proposta nel luglio del 2022, mirava ad ottenere l’accertamento di violazione di marchio e cybersquatting. Yuga Labs, infatti, è la società creatrice di una collezione di NFT intitolata “Bored Ape Yacht Club”, in relazione alla quale l’attrice sostiene di essere titolare di diritti di marchio non registrato. I convenuti avevano creato una collezione di NFT chiamata “Ryder Ripps Bored Ape Yacht Club” allo scopo di indirizzare l’attenzione del pubblico, tramite lo strumento della parodia, nei confronti di messaggi di stampo autoritario inclusi nella collezione dell’attrice. Secondo la decisione della Corte d’appello appena resa nota, sarà una giuria a dover stabilire, tramite l’analisi delle evidenze fattuali e documentali a disposizione, se, effettivamente, la condotta dei convenuti integri violazione di marchio dovuta ad una falsa indicazione di origine dei prodotti identificati sul mercato.
Il sistema delle giurie di stampo statunitense ha condotto, nel corso dei decenni, sia a decisioni condivise sia ad esiti controversi. In un sistema, come quello della violazione di diritti di proprietà industriale e della concorrenza sleale, dove la percezione del pubblico è fondamentale per l’esito di una disputa, vi è forse spazio per valutare un ripensamento di categorie e procedimenti al fine di valorizzare la suddetta percezione. Dall’altro lato, i tecnicismi alla base degli strumenti di tutela richiedono una serie di competenze da ritrovare in giudici allenati ed esperti in materia.